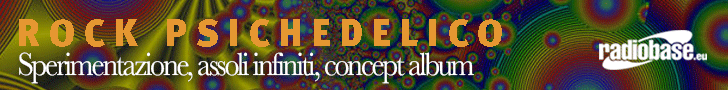In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15

Ascolta il Disco Base della settimana
1. QUEEN "Death On Two Legs"
2. QUEEN "I'm in Love With My Car"
3. QUEEN "You're My Best Friend"
4. QUEEN "Love of My Life"
5. QUEEN "Bohemian Rhapsody"
 I Queen sono stati uno dei fenomeni commerciali più notevoli dell’intera storia del rock; la loro carriera, iniziata nei primi anni Settanta, si è conclusa, di fatto, con la morte di Freddie Mercury dopo vent’anni di ininterrotti successi, più o meno meritati. La critica musicale si è spesso espressa con grande vigore polemico contro la band di Freddie Mercury e Brian May, e spesso, dobbiamo dire, a ragione. Tuttavia, lo stesso Mercury non fece mai mistero del motivo per cui continuava a fare musica: “Amo la bella vita”, diceva, e vendere milioni di dischi è un ottimo sistema per procurarsi i soldi necessari. La musica dei Queen non ha mai voluto nascondere la propria vocazione alla semplicità d’ascolto, al facile appeal da classifica, e sarebbe un errore rimproverare ai dischi della band inglese questo carattere: essi non sono nulla più di ciò che sono stati concepiti per essere.
I Queen sono stati uno dei fenomeni commerciali più notevoli dell’intera storia del rock; la loro carriera, iniziata nei primi anni Settanta, si è conclusa, di fatto, con la morte di Freddie Mercury dopo vent’anni di ininterrotti successi, più o meno meritati. La critica musicale si è spesso espressa con grande vigore polemico contro la band di Freddie Mercury e Brian May, e spesso, dobbiamo dire, a ragione. Tuttavia, lo stesso Mercury non fece mai mistero del motivo per cui continuava a fare musica: “Amo la bella vita”, diceva, e vendere milioni di dischi è un ottimo sistema per procurarsi i soldi necessari. La musica dei Queen non ha mai voluto nascondere la propria vocazione alla semplicità d’ascolto, al facile appeal da classifica, e sarebbe un errore rimproverare ai dischi della band inglese questo carattere: essi non sono nulla più di ciò che sono stati concepiti per essere.
Tuttavia, almeno due album, nella produzione ventennale del gruppo, meritano un riconoscimento di altro tipo: “Sheer Heart Attack” e “A Night At the Opera”, pubblicati a due anni di distanza uno dall’altro, sono accomunati da uno spiccato gusto per forme espressive teatrali, e di fatto costituiscono la vetta compositiva del duo Mercury-May.
“A Night At the Opera”, uscito per la Emi nel 1975, è forse l’esempio più riuscito della vena “pastiche” dei Queen, che seppero coniugare in questo disco la massima creatività compositiva con la massima “ascoltabilità”. Il celeberrimo singolo “Bohemian Rhapsody”, una delle canzoni più conosciute della storia del rock, è solo uno degli episodi in cui questa alchimia diventa vera arte. Il titolo del disco, citazione dell’omonimo film dei fratelli Marx, esprime a parole l’idea di fondo dell’opera, che vuole essere una ideale colonna sonora di una serata di intrattenimento “leggero”. L’Opera fu infatti un genere di rappresentazione di umilissime origini, e anche nel periodo del suo massimo splendore attirava a teatro persone di estrazione sociale diversissima (al contrario della musica da camera e sinfonica, che rimase sempre appannaggio delle classi ricche).
I Queen mescolarono alcuni fra i generi musicali più “popolari” di ogni tempo per creare un sound inconfondibile. L’opera e l’operetta, il vaudeville, il music-hall, il musical di Broadway, l’hard-rock di Who e Led Zeppelin, la vena glam di Marc Bolan e David Bowie confluiscono in “A Night At The Opera” e si fondono magicamente l’uno con l’altro senza soluzione di continuità.
Il disco si apre sulle note di “Death On Two Legs”, mid-tempo acido su cui incede il riff cromatico di May. La voce di Mercury è potente, limpida, altamente espressiva. Il cantante si atteggia a guitto e a dandy e non disdegna il crooning, le asprezze, il falsetto, il canto lirico, l’imitazione comica. La fortissima vena teatrale di Mercury, asse portante dei live-show della band, emerge in modo chiarissimo anche in sede compositiva. L’intero disco potrebbe costituire la colonna sonora di un musical, se solo avesse un’unità tematica: non per nulla la successione dei pezzi e lo stile enfatico e drammatico delle melodie della chitarra lo avvicinano alle musiche che Andrew Lloyd Webber scrisse per “Jesus Christ Superstar”.
L’uso dei cori e delle armonie vocali nei Queen non è mediato dall’uso che ne fecero alla fine degli anni 50 gli Everly Brothers e successivamente Beatles e Crosby Stills & Nash, ma è preso a prestito direttamente dall’operetta e dal musical. Il coro è qui ripristinato nella sua primitiva funzione di contrappunto al solista. Se i Beatles costruivano i cori sopra alla melodia del canto, i Queen spesso li utilizzano a lato di essa, per creare l’effetto teatrale del botta e risposta.
“Lazing On A Sunday Afternoon” è uno sketch vaudeville: la voce è filtrata affinché sembri uscire dal cono di un grammofono. Il pianoforte saltellante, l’atmosfera da Londra di fine ottocento, il testo scopertamente wildeiano mettono a nudo l’ambiguità sessuale di Mercury (“I’m bount to be proposing on a Saturday night”) e le potenzialità mimetiche della sua voce.
“I’m In Love With My Car” è un rock dai toni epici, dedicato da Roger Taylor alla sua passione per le automobili. Molti si sono lasciati sfuggire la perfida autoironia di questo brano, in cui l’esile voce di Taylor scimmiotta Plant e Daltrey – e il machismo di un certo rock – inneggiando all’amore per la propria auto.
L’aspetto parodistico della musica dei primi Queen è spesso sfuggito ai recensori coevi e successivi, che li accusarono di autoindulgenza. Anche nella ballata-pop “You’re My Best Friend”, musicalmente scontata, melodia trita e ritrita, si compie in realtà la parodia della song romantica al pianoforte. I coretti “silly” sono una frecciata, e non una concessione al pop easy-listening.
“’39”, in cui il viaggio dei pellegrini del Mayflower è ricordato nella cornice di un forzato abbandono dai toni malinconici, è un brano di ispirazione folk, sempre infiocchettato di coretti, barcollante sul ritmo di un basso da orchestra di liscio, come in un cabaret d’avanspettacolo: la voce di May pare distante, rassegnata. La chitarra elettrica simula il timbro del violino e della fisarmonica. Brian May rimase sempre incollato al suono corposo e centrato sulle frequenze medie che fu peculiare della sua chitarra fatta in casa, ma non fu in seguito più in grado di incorporarlo nella musica con un tale savoir-faire ironico.
“Sweet Lady”, unico vero hard-rock classico del disco, è una scopiazzatura degli Who suonata al rallentatore, ed è forse l’unica caduta di tono. Tuttavia, anch’essa acquista un altro senso, se si dà credito all’interpretazione “parodistica” dell’opera nel suo insieme. “Seaside Rendez-vous” è l’ideale proseguimento delle atmosfere da music-hall londinese di “Lazing On A Sunday”, trasportate nella Francia della “Belle-epoque”. E’ vera musica da cabaret, con tanto di campanelli e assolo di kazoo; mancano solo le ballerine di contorno.
“The Prophet’s Song” è la traccia più ambiziosa del disco, e ne costituisce l’ideale centro. La “gemella povera di “Bohemian Rhapsody”, come è stata più volte erroneamente definita, è una mini-suite con introduzione acustica, tema hard-rock, bridge corale per voci sovraincise e ritorno al tema. Ricalca nella struttura quel capolavoro che è “My God” dei Jethro Tull, e ne eredita e accentua la teatralità. Qui, più che in ogni altro luogo del disco, il parallelo con il musical è azzeccato. La scena madre della profezia dell’oracolo, di millenaria tradizione letteraria, è tratteggiata con enfasi verbale e melodica. Il cantante è uno, ma capace di infiniti travestimenti: ogni volta che Mercury cambia registro, o che il coro si inserisce nella tessitura, viene data la parola a un personaggio diverso. La sezione centrale è un assolo della voce di Mercury, sovrancisa quattro volte l’una sul’altra in modo non sincronico: più voci cantano la stessa melodia in momenti diversi, partendo a intervalli regolari, in una sorta di contrappunto sfalsato. In realtà questa forma canora è usatissima nelle filastrocche popolari dell’Europa continentale.
Senza soluzione di continuità si passa a una commovente canzone d’amore: “Love Of My Life”. Pur nel pomposo arrangiamento per pianoforte, voce e cori, la melodia mantiene l’aspetto e l’umore della serenata alla finestra. Gli spunti di chitarra elettrica simulano una viola, e la conclusione è affidata a un’arpa, questa volta autentica.
Con “Good Company” il personaggio cambia di nuovo e ci troviamo di fronte a un guitto di strada (Brian May) che racconta la sua triste storia con in braccio un ukulele. Ancora la chitarra elettrica si traveste, stavolta riecheggia l’organetto a manovella.
Alla fine del disco troviamo la leggendaria “Bohemian Rhapsody”: un prodigioso riassunto di alcuni secoli di storia della musica popolare europea e non. Ci sono i canti di Natale in chiesa, i Platters, i Led Zeppelin, l’opera, il melodramma di Monteverdi, le cantate di Bach, le melodie corali di Verdi, Frank Sinatra, il musical di Broadway. Il tutto preso e frullato senza rispetto per successioni cronologiche: il canto da chiesa si innesta sulla power-ballad, assoli di chitarra conducono dalle atmosfere del cabaret a quelle dell’Opera, in un tripudio di sovrancisioni vocali, spunti melodici, riff veementi che simulano le progressioni dei fiati in un’orchestra fra cori angelici e demoniaci, senza perdere mai di vista il tema melodico principale.
La “serata all’opera” si conclude con una trasposizione per chitarra elettrica dell’inno nazionale britannico. Tanto fedele quanto ironicamente “corretta”, “God Save The Queen” è un ultimo sberleffo, rivolto a Sua Maestà la Regina d’Inghilterra e a “Sua Maestà il Re della chitarra”, Jimi Hendrix, che a Woodstock aveva eseguito una versione infuocata (e a sua volta polemica) dell’inno nazionale americano.
L’arte dei Queen è una delle più emblematiche espressioni musicali della “riscoperta” del barocco nel Novecento. La loro versione di una “musica caleidoscopio”, tragica e comica al tempo stesso, aperta verso l’infinitamente grande e verso l’infinitamente piccolo, malata di grandeur e disillusione, un gran calderone in cui mescolare ingredienti impossibili, è per molti aspetti vicina nello spirito al barocco letterario degli inizi del ‘600, e ci regala uno dei momenti più alti di quella follia disorientata – tipicamente novecentesca – priva di certezze sulla via da seguire, che darà origine da un lato alle tendenze minimaliste che segnano tutto il nostro tempo, dall’altro ad alcuni episodi isolati di malinconica smania di grandezza, fra cui vogliamo annoverare anche questo disco.