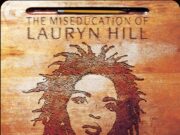In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15

Ascolta il Disco Base della settimana
1. MIKE OLDFIELD "Tubular Bells"
2. MIKE OLDFIELD "Tubular Bells"
3. MIKE OLDFIELD "Tubular Bells"
4. MIKE OLDFIELD "Tubular Bells"
5. MIKE OLDFIELD "Tubular Bells"
 Le primissime attività musicali di Michael Gordon Oldfield – chitarrista folk-rock nativo del Berkshire – coinvolgono gli affetti familiari, dapprima in duo con la sorellina per il long playing a nome Sallyangie (“Children Of The Sun”; Transatlantic, 1969) e poi con il fratello Terry, in gruppo con i Barefeet. Ma Oldfield si fa le ossa soprattutto nella band di Kevin Ayers. Qui inizia a sperimentare con gli strumenti e le prime sovraincisioni amatoriali, fino a quando gli intenti non prendono la consistenza di una vera e propria sinfonia sui generis. Scartata dai più, l’opera così assemblata è presa in consegna dal patron della Virgin, Richard Branson, che riesce a trovare i fondi necessari per produrla, pur dopo faticose sessions di registrazione (al mitico studio “The Manor”) e dopo nuovi durissimi rifiuti da parte delle case di distribuzione.
Le primissime attività musicali di Michael Gordon Oldfield – chitarrista folk-rock nativo del Berkshire – coinvolgono gli affetti familiari, dapprima in duo con la sorellina per il long playing a nome Sallyangie (“Children Of The Sun”; Transatlantic, 1969) e poi con il fratello Terry, in gruppo con i Barefeet. Ma Oldfield si fa le ossa soprattutto nella band di Kevin Ayers. Qui inizia a sperimentare con gli strumenti e le prime sovraincisioni amatoriali, fino a quando gli intenti non prendono la consistenza di una vera e propria sinfonia sui generis. Scartata dai più, l’opera così assemblata è presa in consegna dal patron della Virgin, Richard Branson, che riesce a trovare i fondi necessari per produrla, pur dopo faticose sessions di registrazione (al mitico studio “The Manor”) e dopo nuovi durissimi rifiuti da parte delle case di distribuzione.
“Tubular Bells”, questo il titolo definitivo, è dunque il primo album di un appena ventenne Mike Oldfield, e un esteso brano in due tempi che trae linfa vitale anzitutto da un’assoluta padronanza degli strumenti (suonati quasi interamente dal solo musicista), dei rispettivi spettri timbrici e delle loro concatenazioni creative (tanto naturali quanto artificiali, ma anche virtuose, liriche e geometriche). La sua idea forma suite, sia evoluzione di suono assoluto (in cui i timbri variegati rappresentano poco più di una metafora) che amore per le particolarità pittoriche degli intarsi fonici, è dunque inaudita.
Questo debutto sarà soprattutto ricordato come nuovo fulcro d’ispirazione per il rock di Canterbury e in generale per l’art-rock e le pagine colte di lì a venire (tra tutti, “Heaven And Hell” per Vangelis, “Equinoxe” per Jarre, “Implosions” per Micus, fino a “Passion” di Peter Gabriel e persino ad “Anima” di Vladislav Delay). Per non parlare dell’ampio raggio delle molteplici influenze, che virano con eccezionale fluidità dalla psichedelica alle musiche dal mondo, dal jazz-rock all’hard-rock, dalla pura improvvisazione avanguardistica al panneggio sonoro tout-court, in un tutto che sarà anche annoverato tra i capisaldi della new age dei primordi.
Si può dire che la prima parte sia interamente generata dall’inciso Glass-iano delle tastiere garrule, cui si aggiungono superbi fraseggi di basso e di piano, in una densa tensione di arricchimento progressivo di colori. Quindi il fraseggio di piano di sdoppia in sonata a quattro mani con fiati boliviani e volute di chitarre epiche, che stemperano l’atmosfera in un tema sorrentino per mandolini, con tocchi gaudiosi di glockenspiel. Il clima arieggiato perviene a un cambio di tempo degno delle fantasie tardo-romantiche, in cui l’inesauribile afflato creatore è ormai contemplazione fervente; il ritorno al tempo primo aggiunge accenti mediorientali e nuove variazioni del leit-motiv, fino a che la quiete non è squarciata da schitarrate a mo’ di fanfare. Una straordinaria cesura lancia un episodio di danza indiana, che infine lascia il posto a un nuovo silenzio di chitarre folk (sia mormoranti che in crescendo), organo in lontananza e rintocchi diafani.
La chiusa è un’alta lezione sul crescendo agogico a mo’ di “Bolero” (e un riassunto dell’intero brano) in cui gli strumenti entrano in fila indiana a eseguire un motivo incantato di dieci battute e indi a contrappuntare in sospensione, sopra un raffinato nastro di riff fusion, fino a che l’intera prodigiosa messinscena (culminante proprio nelle campane tubolari del titolo) non si dilegua magicamente su un arpeggio di chitarra classica.
Il secondo movimento riprende armoniosamente da questo clima acustico. Scie di florilegi in dondolio esoterico si accavallano in un’intricata selva (che mantiene comunque un rigore tutto Bach-iano di modulazioni e contro-modulazioni) che dopo circa cinque minuti regredisce a minuetto agreste per organo, per poi prendere il volo trasportato dal mandolino pregno d’eco e da un coro femminile. Finalmente (dopo quasi dieci minuti) l’armonia errabonda dilaga in uno ieratico tema rinascimentale scandito dai timpani e letteralmente sbrindellato da una cortina di dissonanze. Nuovamente marziale, la sarabanda si evolve in jam progressiva con rantoli animaleschi e pianoforte metronomico, nel mezzo contesa tra riff stentorei e improvvisazioni southern, ad aumentare la suspense. Il tutto si schianta contro una corale sovrumana d’organo religioso e chitarre celestiali, che procede sinusoidale ad libitum (pure riprendendo elementi dall’attacca) fino a una schiarita intonata dal solo organo. Il gran finale a sorpresa (un’impeccabile citazione di un gaio tema arcinoto), culmine di queste gesta aggraziate, chiude la perfetta catena sinfonica senza residui.
Il britannico Oldfield, alle prese con un debutto pesante (definito immediatamente mitico già solo per l’esigua parte di batteria), affascinato dal senso mistico che irrora “Rainbow In Curved Air” di Riley, cava il più memorabile esempio di musica della compensazione. È il disco con cui il rock strumentale varca definitivamente la soglia d’arte maggiore, secondo un riciclo di gradi in cui la possibilità di distinguere l’alterazione fatata dalla partitura scritta è tanto inesorabile quanto persa in partenza. A dirigere il mirabile fraseggio vi è solo la sensazione di armonia ridotta ai minimi termini, appena assorbita dalle filigrane instancabili, e perciò ancor più fervida, catartica, esplorante. La voce che interpella gli strumenti nel finale della prima parte è di Vivian Stanshall, poeta, narratore e cantante della Bonzo Dog Doo-Dah; le boccacce d’indemoniato della seconda sono dello stesso Oldfield, la pratica risposta ai paletti discografici che volevano uno straccio di canto melodico per rendere il disco un po’ più commerciale. Il compositore nella chiusa si è appropriato di “Sailor’s Hornpipe” forse prevedendo – viceversa – il saccheggio dell’incipit (consegnato a “L’esorcista” dello stesso anno), uno dei più grandi di sempre. Seguito indegnamente da “Orchestral Tubular Bells” (1975), “Tubular Bells II” (1992), “Tubular Bells III” (1998), “The Millennium Bell” (1999) e “Tubular Bells 2003” (2003), con cui conferma l’inferiorità della sua discografia successiva.