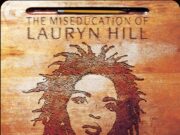In onda tutte le sere alle 20,15 - 22,15 - 00,15
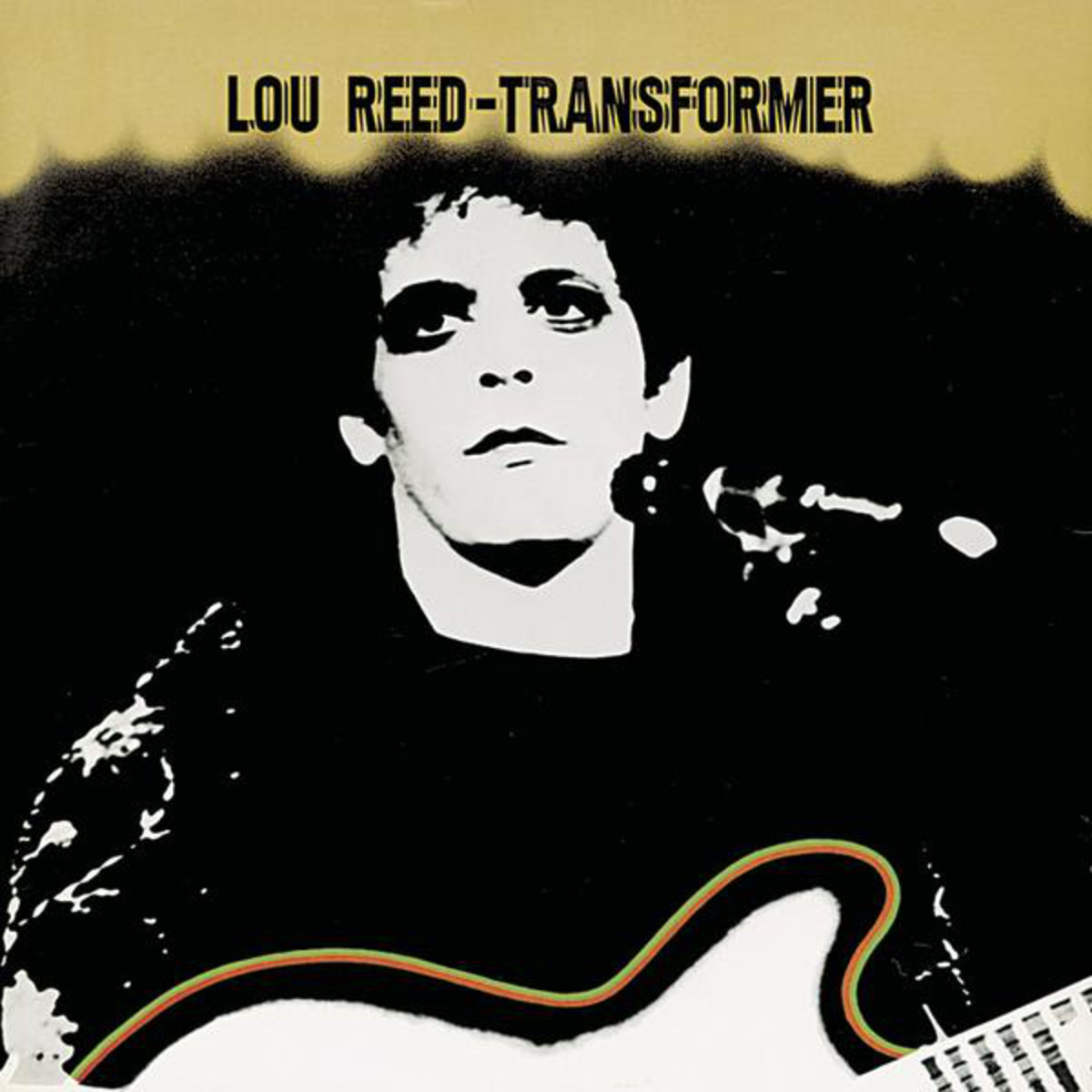
Ascolta il Disco Base della settimana
1. LOU REED "Vicious"
2. LOU REED "Perfect Day"
3. LOU REED "Hangin' Round"
4. LOU REED "Walk On The Wild Side"
5. LOU REED "Wagon Wheel"
 Uno dei segreti della longevità professionale di Lou Reed può ricercarsi anche nell’essere stato, nel corso della sua carriera, costantemente in movimento. Gli si deve riconoscere di avere sempre avuto la capacità, nel bene e nel male, di mutare pelle, di sapersi rinnovare, senza mai voltarsi indietro.
Uno dei segreti della longevità professionale di Lou Reed può ricercarsi anche nell’essere stato, nel corso della sua carriera, costantemente in movimento. Gli si deve riconoscere di avere sempre avuto la capacità, nel bene e nel male, di mutare pelle, di sapersi rinnovare, senza mai voltarsi indietro.
L’immagine in bianco e nero che lo ritrae, truccato e imbellettato come una geisha, l’espressione attonita di un Frankestein effemminato, con sotto di lui la sagoma di una chitarra profilata in arancione e verde – immortalato per la cover di questo disco dal grande Mick Rock, “l’uomo che ha fotografato gli anni 70” – non è quindi altro che una sfaccettatura, una delle sue molteplici personalità artistiche. Cerchiamo allora di individuare, facendo un passo indietro, la ragione di questa metamorfosi che lo trasformò da artista alternativo a icona glam.
Nell’estate del 1972 Lou Reed si trova in una situazione artistica paradossale. Ha scritto e interpretato – con i Velvet Underground, gruppo che si rivelerà fra i più influenti e importanti della musica rock – alcune fra le più belle e innovative canzoni degli ultimi anni ma, ciò nonostante, si trova in un vicolo cieco che lo ha fatto sprofondare nella più cupa incertezza.
Il suo primo album solista, il folkeggiante “Lou Reed”, malgrado alcune buone canzoni, non però all’altezza dei suoi lavori precedenti; forse anche a causa di una pessima produzione, è stato un flop commerciale clamoroso; è pressoché sconosciuto al grande pubblico e la sua carriera artistica è sull’orlo del fallimento.
Contemporaneamente, un nuovo fenomeno sta vivendo la sua grande ma breve stagione: il glam-rock, il “rock dei lustrini”. Sessualità androgina e polimorfica, look fantasmagorico e volutamente kitsch, musica trasgressiva e decadente.
La nuova generazione non si riconosce nei grandi ideali che hanno caratterizzato le oceaniche adunate pacifiste, tutte “peace & love”, dei movimenti giovanili degli anni 60. Dei loro ingenui fratelli maggiori, gli psichedelici hippie “figli dei fiori”, hanno perso l’innocenza e gli slanci. Sono ragazzi vanitosi, cattivi, tutti “”sesso droga e rock’n’roll”” e quello che vogliono non è altro che divertirsi, all’insegna del disimpegno e della spensieratezza. L’appagamento dei loro desideri lo trovano incarnato nel glam: sesso, ambiguità, eccesso; ma anche sfida alle convenzioni borghesi, il rifiuto dei modelli dominanti, il gusto per il travestimento e il ripensamento dell’identità maschile portato ai limiti più estremi. I performer del glam si atteggiano teatralmente come dive anni 30, si truccano, indossano gioielli, parrucche, abiti coperti di lustrini e paillettes. Dichiarano sfrontatamente la loro bisessualità minando alla radice il concetto di identità e di sessualità, indirizzando il movimento glam verso un processo di “sessualizzazione” sino ad allora inedito nel mondo del rock.
Nell’Inghilterra, patria del glam, si distinguono artisti come Gary Glitter, Alice Cooper, Bryan Ferry dei Roxy Music, Marc Bolan dei T-Rex ma, all’apice del successo con la saga rock-fantascientifica “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars”, in cui impersona un alieno, l’androgino “Ziggy Stardust”, ispirato al protagonista della pièce teatrale di Andy Warhol “PORK”, in quel momento c’è David Bowie. Il futuro Duca Bianco non ha mai fatto mistero di essere stato fortemente influenzato dall’accentuata teatralità dei Velvet Underground e di avere sperimentato quelle sonorità originariamente esplorate proprio da loro. Ha reso omaggio a Lou Reed, sia dedicandogli uno dei brani più travolgenti di “Hunky Dory”, “Queen Bitch”, in cui imita volutamente la sua voce, sia eseguendo, nei concerti, canzoni tratte dal repertorio dei Velvet Underground. Non può quindi accettare che un talento così grande vada sprecato, che proprio colui che ritiene uno dei suoi maestri finisca nell’oblio. Per queste ragioni, molto generosamente, come raramente avviene fra artisti, si propone di collaborare alla produzione del suo prossimo album, ulteriore possibilità che la Rca offre a Lou Reed per riscattarsi dall’insuccesso del lavoro precedente.
Lou Reed non rifiuta certo una simile opportunità e si trasferisce immediatamente a Londra, dove si trova perfettamente a proprio agio nell’ambiente glam, così eccentrico, effervescente, vitale, intensamente creativo, tutto basato sull’immagine e l’esteriorità, erede naturale della Factory di Andy Warhol (suo vate e primo manager), in cui il glam affonda le proprie radici. In fondo la sensibilità “camp”, in altre parole l’amore per l’artificio e l’esagerazione, derivano direttamente dall’estetica “”pop”” di Warhol. Reed ammira molto l’atteggiamento sofisticato e sessualmente ambiguo di David Bowie, è impressionato dalle sue doti di affabulatore, dalla sua organizzazione, dalla sua astuta e intelligente manipolazione dei mass-media come parte integrante di un evento artistico, tanto simile a quello di Warhol. A sua volta Bowie è in soggezione di fronte a Lou Reed, tanto che successivamente avrebbe dichiarato “Lou accettò la mia collaborazione come produttore, era così generoso, ne ero sconvolto. Avevo tante idee ma ero intimidito dal lavoro che aveva fatto. Anche se fra noi c’erano pochi anni di differenza, Lou aveva un tale bagaglio di esperienza!”. Lo invita, come ospite d’onore, a un suo concerto al Royal Festival Hall, e indice una conferenza stampa per pubblicizzare la loro musica e la loro immagine. Vuole avvicinare il suo pubblico a Lou Reed, ma anche riconoscere pubblicamente in lui una fonte d’ispirazione meritevole d’attenzione e dichiara “”Lou ha portato il rock nell’avanguardia. Ha creato l’ambiente nel quale inserire la nostra visione più teatrale. Ci ha dato la strada e i paesaggi e noi li abbiamo popolati. Lou Reed ha creato lo Zeitgeist verbale e musicale””. Non solo decreta così, di fatto, l’ingresso di Lou Reed nel glam-rock ma, andando ben oltre la semplice produzione, contribuisce anche alla creazione di quello che sarà il suo personaggio glam, decadente e maudit, “il Fantasma del rock”: tuta nera, trucco giapponese, occhi bistrati, unghie laccate di nero.
Bowie, la cui grandezza sta anche in questo, paga così, con un gesto d’amore e di gratitudine, il debito verso il suo idolo, in quel momento un po’ in declino; ma la pubblicazione dell’album – il cui titolo paradigmatico sarà “Transformer”, un esplicito riferimento al travestitismo di chiara impronta glam – sancirà la fine del loro sodalizio.
Da una parte c’è David Bowie, colto, esotico, sognatore, sensibile e irritabile, forte ma non certo duro come Reed. Dall’altra parte c’è il vero Lou Reed, veloce, nervoso, carico di tensione e vibrazioni newyorkesi, sarcastico, duro, aggressivo. A fare da trait d’union, fra questi due straordinari artisti, c’è il solido, fido Mick Ronson, di cui Bowie si avvale per la produzione. Chitarrista geniale e potente, re della distorsione e dell’assolo “lancinante”, musicista completo, creatore del sound spaziale di “Ziggy Sturdust”, che si rivela determinante nel fornire un contributo prezioso alla creazione di “Transformer”. Se Bowie può essere per Lou Reed un perfetto collaboratore, come lo fu Warhol, che gli offre suggerimenti, lo incita e lo incoraggia, Ronson può essere un perfetto sostituto, anche se meno innovativo e sperimentale, diciamo più commerciale, di John Cale.
Lou Reed canta le sue canzoni, struttura base e melodia, accompagnandosi con la chitarra. Intorno alle sue armonie, semplici ma efficaci, Ronson avvolge i sobri, raffinati, accattivanti arrangiamenti. Ronson, infatti, compone gli arrangiamenti degli archi, dei fiati e di tutte le grosse parti di piano che, insieme alla sua chitarra “nasale”, da lui suonata con un pedale wah-wah premuto a metà, conferiscono all’album un suono immediatamente identificabile.
La line up scelta è di grande livello: oltre a Lou Reed (chitarra acustica), a David Bowie (backing vocals-mixing), a Mick Ronson (chitarre, pianoforte, coro), a Herbie Flowers (basso, tuba, strumenti vari), spiccano Klaus Voormann, il celeberrimo bassista che ha lavorato per i Beatles e per la Plastic Ono Band di John Lennon (basso, chitarra-basso) e Ronnie Ross (Sax). Un disco che nel suo contesto suona perfetto anche grazie alla surreale, confidenziale, libidinosa, carezzevole voce di Lou Reed.
Il rock metropolitano, sotterraneo, disturbante, si è sposato con l’agrodolce, edonistico glam e il frutto di questa unione è un vero gioiello, una collana di perle preziose, piccoli capolavori ancora oggi attualissimi che mantengono nel tempo una freschezza incredibile e ancora intatta tutta la loro forza.
“Scrivere canzoni è come recitare e riservarsi la parte del protagonista, così cerchi di scrivere i versi migliori che puoi. Sono parti brevi e devi adattarti a interpretare tutti i personaggi. Scrivo attraverso gli occhi di qualcun altro, osservo sempre con attenzione le persone su cui sto per scrivere una canzone, poi mi trasformo in loro”. “Ho sempre pensato che sarebbe stato divertente presentare alla gente personaggi che forse non avevano mai incontrato prima, o che non avevano mai voluto incontrare. Quel genere di persone che a volte vedi alle feste, ma che non osi avvicinare. Questo è uno dei motivi principali per cui ho scritto quelle canzoni”.
L’esperienza personale emerge sempre in ciò che si scrive, ma in queste dichiarazioni possiamo probabilmente trovare la chiave di lettura per interpretare la maggior parte dei testi di “Transformer”, che non hanno assolutamente nulla da invidiare alle liriche di velvettiana memoria.
Il testo fantasioso del primo brano, “Vicious”, gli fu suggerito da Warhol che gli chiese di scrivere una canzone sull’essere viziosi e con una sublimazione sadomaso, per battere l’amante, al posto della frusta viene usato un fiore “Vicious/ you hit me with a flower/ You do it every hour/ oh baby, you’re so vicious”. Rock allegro, giocoso, cantato da Lou Reed in modo ironicamente ambiguo. Arrangiamento volutamente scarno per far risaltare il riff distorto, semplice ma efficace, della chitarra nervosa di Ronson.
“Andy’s Chest”, brano che faceva parte dell’album “perduto” dei Velvet Underground pubblicato solo nel 1985, è una morbida, tenera, surreale canzone d’amore dedicata all’amico Warhol che, nel 1968, rischiò di morire per mano di una squilibrata che gli sparò in pieno petto. Rallentata rispetto alla versione già incisa, mantiene comunque un andamento gaio ed è piacevolmente arricchita dai cori.
Cosa dire di “Perfect Day” se non “perfect song”. La canzone che ognuno vorrebbe sentirsi dedicare. Bellissima ballata dal sapore jazzy, dolce e malinconica. Incantevoli gli arrangiamenti per pianoforte e archi di Ronson L’arte poetica e melodica di Reed si eleva al di sopra di tutto e lo fa con una linearità, una semplicità e una poesia tali da lasciarci stupefatti. Con un’interpretazione emotivamente toccante, rappresenta, in poche battute, come può essere un giorno perfetto, per sfuggire alle angosce quotidiane e ai demoni notturni. Commovente. “Just a perfect day/ you made me forget myself/ I thought I was someone else/ someone good”, ma anche ammonitrice “You’re going to reap just what you sow”. Pianoforte dal ritmo boogie e chitarra da rock’n’roll classica in “Hangin’Around”, per ridicolizzare alcuni personaggi, probabilmente conosciuti recentemente a Londra, che avrebbero la pretesa di essere trasgressivi e invece sono solo patetici.
Atmosfera jazz, ritmo sincopato, semplice ma efficace, sostenuto dalla famosa linea di basso di Herbie Flowers (ottenuta con un contrabbasso doppiato con un basso elettrico), dalla chitarra acustica di Lou Reed e dai coretti ammiccanti delle “Thunder Thigs” (Le Cosce Tonanti!) per “Walk On The Wild Side”, un giro sul lato selvaggio. Warhol avrebbe dovuto adattare per il teatro un libro di Nelson Algren, intitolato appunto “Walk On The Wild Side” e chiese a Reed di scrivere alcune canzoni. Il progetto sfumò, ma Reed ne riprende il tema per questa canzone e ai personaggi del libro sostituisce le familiari figure che frequentavano la Factory, il laboratorio collettivo creato da Warhol, una specie di corte dei miracoli che ospitava gente di ogni inclinazione, tutti in cerca dei loro “quindici minuti di celebrità” che, secondo la teoria del re della Pop Art, non si potevano negare a nessuno. Ogni strofa della canzone tratteggia un carattere, è un flash che cristallizza un attimo metaforicamente rappresentativo nella vita del personaggio o una sua provocatoria abitudine, presentata come naturale nella propria drammaticità che in ogni caso traspare. Destabilizzando il comune senso del pudore, senza mezzi termini e senza vergogna, Reed svela il mondo sommerso di una New York trasgressiva, malata, viziosa e perduta; mostra il lato oscuro delle cose con assoluta chiarezza e, come nel suo stile, senza alcuna pretesa di giudicare ma inducendo a riflettere, ad aprire la mente, a scoprire che vi sono altri mondi che non combaciano con la nostra realtà. Il sax suadente di Ronnie Ross ci toglie dall’imbarazzo di essere entrati nella loro vita privata, per noi scandalosa, “selvaggia”, per loro semplicemente la quotidianità, vissuta serenamente, con naturalezza. “Walk On The Wild Side” fu il primo singolo tratto dall’album e anche la prima canzone che conteneva espliciti riferimenti al travestitismo “Holly came from Miami F.L.A./ hitch-hiked her way across the U.S.A./ Plucked her eyebrows on the way/ shaved her leg and then he was a she”, al sesso orale “But she never lost her head / even when she was givin’ head”, alla prostituzione maschile “Little Joe never once gave it away/ everybody had to pay and pay”, a essere tranquillamente trasmessa per radio nei paesi non anglofoni; anche l’inglese Bbc, non capendo il vero significato di certe frasi gergali, la trasmise integralmente. Solo in America le radio pretesero una versione espurgata.
Con “Make Up”, brano melodico, leggero, scandito dalla tuba di Herbie Flowers, Lou Reed dichiara la propria simpatia per i travestiti e i gay. Nel suo ritornello c’è, infatti, lo slogan del “Gay Liberation Front” “Now, we’re coming/ out of our closets/ Out on the streets”
“Satellite of Love” è una delle ballate glam più belle di sempre. Nel coro si distingue l’eccezionale, incredibile voce di Bowie che tocca note altissime. La base armonica è più aperta, costruita in gran parte da accordi in tonalità maggiore, e lo strumento principe è il pianoforte. Il testo, follemente ironico, tratta con scherno il tema della gelosia “I’ve been told that you’ve been bold/ with Harry, Mark and John Monday/ and Tuesday Wednesday through Thursday/ with Harry, Mark and John”.
Sul rockeggiante “Wagon Wheel”, gira la leggenda metropolitana che vuole sia una composizione di David Bowie. Dal testo, reediano a tutti gli effetti, emerge già un certo disagio nel rapporto di coppia, un’inquietudine e un’insofferenza che probabilmente rispecchiano la sua vita privata. Forse si tratta del primo passo che lo porterà poi a rifugiarsi nelle proprie ossessioni con “Berli””, storia d’amore, morte e droga.
Registrazione in presa diretta per “New York Telephone Conversation”, ritmo che sa tanto di vaudeville, con pianoforte stile cabaret, basso e cimbali. In alcune strofe Bowie doppia Reed di un’ottava superiore, dando al brano un tono divertente e frivolo. Anche questo testo è dedicato a Warhol, noto nel suo ambiente per essere un incallito conversatore e un abile pettegolo. Si sapeva che passava ore e ore al telefono, con amici e collaboratori, parlando di tutto ma soprattutto, registrando tutto; alcune di queste registrazioni vennero utilizzare per la pièce teatrale “Pork” e per il libro “A”. Rock energico, con Bowie ai cori e Ronson alla chitarra che ci regala un bellissimo assolo, per “I’m So Free”, che fissa un momento felice e spensierato del protagonista. Una curiosità: “Mother Nature” è in gergo la marijuana e i suoi figli ne sono i consumatori.
Il brano che chiude l’album è “Goodnight Ladies”, con Herbie Flowers alla tuba accompagnato dai suoi “amici”, una tipica orchestrina dixieland. Straordinaria e intensa l’interpretazione di Reed per narrare la solitudine e l’abbandono: “Oh-wow-wow, something tells me that you’re really gone you said we could be friends but that’s not what I want Ah, anyway, my TV dinner’s almost done it’s a lonely Saturday night I mean to tell you, it’s a lonely Saturday night”.
“Transformer”, alla cui pubblicazione avvenuta nel novembre 1972 fece seguito uno straordinario tour, fu un successo clamoroso che raggiunse i vertici di tutte le classifiche, trasformando Lou Reed da figura underground di culto in rockstar. Si rivelò inoltre fondamentale per la sua vita professionale, non tanto e non solo per il suo valore intrinseco, ma perché rappresentò la sua rinascita artistica e gli restituì quella fiducia nelle proprie capacità smarrita dopo lo scioglimento dei Velvet Underground.
Per l’epoca fu un album scandaloso, iniziando dalla copertina con raffigurata sul retro una doppia immagine dello stesso modello, in versione sia da travestito (discinta e sexy), sia maschile cui infilarono ironicamente una banana nei pantaloni per simulare un’erezione. Pateticamente l’edizione italiana fu censurata con un fascione dorato che tagliava orizzontalmente la copertina coprendo, con la scritta “Produced by David Bowie and Mick Ronson”, entrambe le foto all’altezza dell’inguine.
L’impatto poi che ebbe per il suo contenuto sessuale è stato ormai dimenticato, ma fu un disco shock, rivoluzionario per il linguaggio usato, anticipatore del cambiamento di costume e morale, un manifesto glam oltraggioso in ogni sua parte, la testimonianza di un modo di vivere e di vedere il mondo essenziale per capire gli anni Settanta. Oggi le drag queen popolano i talk-show televisivi e i gay vivono e rivendicano la loro sessualità alla luce del sole, ma tutto questo allora era appannaggio solo di un ristretto ambito artistico.
Il merito di Lou Reed fu quello di sublimare il vizio sottraendolo al giudizio della morale corrente, di far emergere, di “legittimare” un universo sommerso che creava imbarazzo e suscitava scandalo, rappresentandolo nel suo crudo realismo, narrandolo senza parafrasi e senza autocompiacimento, con quel tocco di poesia necessario per renderlo affascinante e umano. Ma il contrasto fra la sua vita privata e l’immagine pubblica era stridente. Lou Reed si sentì ben presto intrappolato nel ruolo di “Fantasma del rock”, nel quale non si era mai riconosciuto sino in fondo, e che, probabilmente, utilizzò solo come mezzo per fare finalmente conoscere le sue canzoni a una platea più vasta.
Abbandonerà quindi i panni glam, che rimarranno per lui solo una breve parentesi, prendendone anzi garbatamente, ma decisamente le distanze e, nella più assoluta mancanza di continuità, ci regalerà quel capolavoro indiscusso che è “Berlin”, album torturato e poetico, il suo autoritratto artistico, con il quale estese i confini della propria arte.
Gli scenari vanno e vengono, se ne creano di nuovi ma fortunatamente la musica resta. “Transformer” è ormai un classico, un album memorabile, indimenticabile, senza tempo. A tutt’oggi rimane il lavoro di Lou Reed più conosciuto, più commercializzato, un esempio, se ancora ce ne fosse bisogno, di come la qualità e il successo di vendite possono perfettamente coesistere.
Stefania Zanorelli