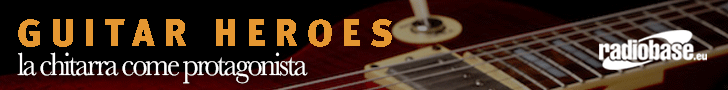In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15

Ascolta il Disco Base della settimana
1. ROLLING STONES "Brown Sugar"
2. ROLLING STONES "Wild Horses"
3. ROLLING STONES "You Gotta Move"
4. ROLLING STONES "Bitch"
5. ROLLING STONES "Sister Morphine"
 Ebbene sì, questo è l’album con in copertina i jeans sdruciti (ed evidentemente ben guarniti) e la cerniera vera e regolabile (almeno nelle prime edizioni su vinile), il tutto naturalmente firmato Andy Warhol. Va da sé che per gli Stones più c’era scandalo e meglio andava, anche se ai tempi di questo “Sticky Fingers” la prima oltraggiosa fase, quella più cruda ed efferata, aveva già ceduto il passo a una progettualità sonora netta, forse meno ricca e visionaria (non si improvvisa né si rimpiazza un Brian Jones da un giorno all’altro) ma non per questo priva di ricercatezze, come garantiva la produzione dell’ormai fido Jimmy Miller (artefice nello stesso periodo anche del caleidoscopio musicale dei Traffic). Più musica che scelleratezze, quindi, il profilo affilato di un rock intenso e intransigente, ancora ben lontano dal cedere le armi alla maniera e – proprio per questo – capace di suonare a tutt’oggi superbamente vero, stringente e attuale.
Ebbene sì, questo è l’album con in copertina i jeans sdruciti (ed evidentemente ben guarniti) e la cerniera vera e regolabile (almeno nelle prime edizioni su vinile), il tutto naturalmente firmato Andy Warhol. Va da sé che per gli Stones più c’era scandalo e meglio andava, anche se ai tempi di questo “Sticky Fingers” la prima oltraggiosa fase, quella più cruda ed efferata, aveva già ceduto il passo a una progettualità sonora netta, forse meno ricca e visionaria (non si improvvisa né si rimpiazza un Brian Jones da un giorno all’altro) ma non per questo priva di ricercatezze, come garantiva la produzione dell’ormai fido Jimmy Miller (artefice nello stesso periodo anche del caleidoscopio musicale dei Traffic). Più musica che scelleratezze, quindi, il profilo affilato di un rock intenso e intransigente, ancora ben lontano dal cedere le armi alla maniera e – proprio per questo – capace di suonare a tutt’oggi superbamente vero, stringente e attuale.
E’ il caso di dire dalla prima all’ultima nota, visto che l’inizio è affidato a quel mostro di “Brown Sugar”, micidiale ordigno stritolaclassifiche in cui trovano cittadinanza l’inimitabile (e perciò imitatissimo) riff di Keith Richards, l’animalesca vocalità di Mick Jagger, il battito asciutto di Charlie Watts, la chitarra sorniona di Mick Taylor, una profusione incalzante di piano (Ian Stewart) e di sax (Bobby Keyes), infine la puntualità inesorabile del basso di Bill Wyman: il risultato è un rock’n’roll che chiama a raccolta la voglia di sentirsi vivere, ora e qui, con tutto il nostro bello e l’immancabile brutto (cattivo, reale, vero). Perizia, innanzitutto: perizia ineguagliabile nell’esporre i conati più aspri e la più languida delle dolcezze, come dimostra la stratosferica “Sway”, ballata in bilico tra calor bianco e malinconia, tensione palpabilissima in mezzo a chitarre lacerate e strazianti, il piano pressante e dolceamaro del buon Nicky Hopkins, la teoria discreta degli archi (Paul Buckmaster) e – signori miei – un drumming da accademia delle viscere, da sudore freddo dalla fronte ai polpacci, offerto da quel taciturno padrone di piatti e rullante che risponde al nome di Charlie Watts.
Con “Wild Horses” l’aria si fa decisamente più rarefatta, il paesaggio che si impone è quello campestre e nebbioso di un qualche pomeriggio in terra d’Albione, contorno ottimale per lo straordinario substrato acoustic-folk di questa ineffabile ballatona, consumata tra il languido estenuarsi delle corde vocali di Jagger e uno sdilinquirsi melodico francamente lezioso, anche se con ogni probabilità c’è chi (s)venderebbe un rene per scrivere – ancora oggi – un pezzo così. Meno celebre, ma assolutamente sconvolgente, è la successiva “Can’t You Hear Me Knocking”, rhythm n’ blues dalle torride venature funky-soul, che rende pressoché inutili anche i migliori Black Crowes, energia scomposta eppure stilizzata (basso e batteria nel cuore della mischia, chitarre insidiose e la voce che insegue torridi punti di rottura), con in più l’acidità verticale dell’organo (Billy Preston), le palpitazioni orizzontali delle congas (Rocky Duon) e uno splendido lavoro di Keyes al sax: quasi otto minuti di goduria, un amplesso memorabile e convulso tra le cosce smaniose del rock. Tiriamo il fiato con una cover essenziale e roots di “You Gotta Move”, in cui le voci ebbre di Jagger e Richard sono il contraltare buffo di un monumentale Taylor alla slide. Ma c’è poco da star tranquilli, perché “Bitch” è dietro l’angolo, rock posseduto da spiritelli incontenibili, come il soul che scroscia dagli ottoni di Keyes e Jim Price, come il blues che sfregola nella chitarra di Taylor, come il funky scoppiettante della serratissima ritmica, treno a precipizio su binari indistruttibili.
Binari che ci portano ad attraversare l’agra mestizia di “I Got The Blues”, un soul maestoso in cui ogni elemento gioca bene (ma su tutti ancora lodi al grande Mick Taylor e all’assolo d’organo di Preston, autentico totem di languore e acidità). C’è la penna della musa-amante Marianne Faithfull nel testo della celebre “Sister Morphine” (dramma tossico narrato con la pietosa crudeltà di un Lou Reed), folk palpitante e nervoso a cui Jagger dona voce sangue e vocalizzi accorati, orlato da sordi pestaggi di piano (il compianto Jack Nitzsche) e dalla slide febbrile di Ry Cooder (un dolce respiro, un vento che taglia la faccia).
“Dead Flowers” è invece un graziosissimo quadretto folk blues intarsiato da due chitarre in vena di malie, uno degli innumerevoli gioielli minori (?) di una carriera prodigiosa, mentre la conclusiva “Moonlight Mile” imbastisce una ballata ebbra, sospesa, in apnea: messa sul piatto la perizia di cui abbiamo già parlato e richiamati a sé tutti i geni ispiratori (un eco di soul, il paterno blues, l’autorità del folk), ecco che una sezione d’archi in vena d’esotismi può copulare soavemente con la più sanguigna delle chitarre ritmiche, e niente sembra troppo, niente stona, tutto accogliamo tra un battito e l’altro del cuore.
A questo punto, cosa dire che non sia già stato detto? Se dal rock vi aspettate tanto l’energia quanto la più canaglia delle tenerezze, in “Sticky Fingers” potreste trovare tutte le risposte del caso e molto altro ancora. Più che la musica, negli Stones, vale l’esposizione (della musica stessa), anche se a loro va l’enorme merito di aver fatto coincidere le due cose, tanto che poi non sono più state le stesse. Come del resto le nostre vite.