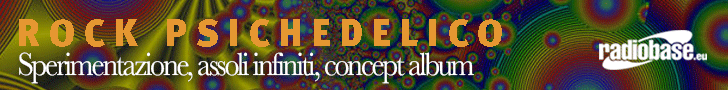In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15

Ascolta il Disco Base della settimana
1. TEARS FOR FEARS "The Hurting"
2. TEARS FOR FEARS "Mad World"
3. TEARS FOR FEARS "Pale Shelter"
4. TEARS FOR FEARS "Change"
5. TEARS FOR FEARS "Start Of The Breakdown"
 Doverosa premessa: questa pietra miliare arriva con almeno dieci-quindici anni di ritardo. Capita, quando per un gruppo c’è da scegliere tra due capolavori e non si sa decidersi: da un lato “The Hurting”, la purezza abbacinante di un esordio che sposava cantautorato e sintetizzatori, introspezioni dolorose e ritornelli a presa rapida; dall’altro “Songs From The Big Chair”, il classico disco della consacrazione, praticamente perfetto nel fotografare l’evoluzione di una band matura, ormai fuori dalle secche di un genere che stava perdendo il suo abbrivio e pienamente consapevole delle sue formidabili doti di songwriting. Alla fine l’ha spuntata il primo (che incidentalmente è anche il preferito del duo inglese). Forse proprio in virtù dei suoi ritornelli memorabili, di quei quattro-cinque instant classic da brividi. A partire da quella “Mad World” risorta a nuova vita dopo la sua inclusione in “Donnie Darko” (2001). La casta versione di Gary Jules per piano e voce, usata per sottolineare il momento di pathos corale di un film che avrebbe segnato la cultura giovanile del decennio, segnalava un dato di fatto: spogliato della coltre di suoni sintetici – nonché inevitabilmente datati, dal basso fretless alla drum machine, dagli effetti di synth all’assolo di sax – il brano rivelava un cuore melodico e dolente, adatto a riscaldare anche il freddo del Duemila. Così come nel film si tornava indietro a quel famigerato decennio, quasi a ritrovarvi la radice del mal di vivere contemporaneo, in molti hanno fatto probabilmente un analogo percorso a ritroso in campo musicale, rinvenendo negli 80’s quel che si era sempre negato ci fosse, ovvero melodie, calore umano, dolore persino. In sintesi, belle canzoni.
Doverosa premessa: questa pietra miliare arriva con almeno dieci-quindici anni di ritardo. Capita, quando per un gruppo c’è da scegliere tra due capolavori e non si sa decidersi: da un lato “The Hurting”, la purezza abbacinante di un esordio che sposava cantautorato e sintetizzatori, introspezioni dolorose e ritornelli a presa rapida; dall’altro “Songs From The Big Chair”, il classico disco della consacrazione, praticamente perfetto nel fotografare l’evoluzione di una band matura, ormai fuori dalle secche di un genere che stava perdendo il suo abbrivio e pienamente consapevole delle sue formidabili doti di songwriting. Alla fine l’ha spuntata il primo (che incidentalmente è anche il preferito del duo inglese). Forse proprio in virtù dei suoi ritornelli memorabili, di quei quattro-cinque instant classic da brividi. A partire da quella “Mad World” risorta a nuova vita dopo la sua inclusione in “Donnie Darko” (2001). La casta versione di Gary Jules per piano e voce, usata per sottolineare il momento di pathos corale di un film che avrebbe segnato la cultura giovanile del decennio, segnalava un dato di fatto: spogliato della coltre di suoni sintetici – nonché inevitabilmente datati, dal basso fretless alla drum machine, dagli effetti di synth all’assolo di sax – il brano rivelava un cuore melodico e dolente, adatto a riscaldare anche il freddo del Duemila. Così come nel film si tornava indietro a quel famigerato decennio, quasi a ritrovarvi la radice del mal di vivere contemporaneo, in molti hanno fatto probabilmente un analogo percorso a ritroso in campo musicale, rinvenendo negli 80’s quel che si era sempre negato ci fosse, ovvero melodie, calore umano, dolore persino. In sintesi, belle canzoni.
Forse, però, era troppo tardi. Almeno per far rinsavire quella parte della critica che per anni aveva snobbato la premiata ditta Orzabal-Smith. Qualche esempio? Nella bibbia “Post-punk” di Simon Reynolds se ne fa menzione solo per ricordare la battutaccia di Paul Morley – giornalista musicale prestato agli Art of Noise – secondo il quale “una chiave inglese è intrinsecamente più interessante del cantante dei Tears For Fears”. Neanche una riga su di loro nell’Enciclopedia rock anni 80 a cura di Riccardo Bertoncelli (620 voci!). E tra i “Mille dischi fondamentali” del consolidato duo Cilia-Guglielmi? Non pervenuti.
Tre esempi a caso, indicativi però di come il marchio della band di Bath sia stato spesso superficialmente associato a un elettropop fatuo, da classifica, senza riconoscergli quella profondità d’intenti e quella dignità autoriale che lo contraddistinguevano. Tutto ciò sempre a patto che non possa già bastare un attacco come quello di “Pale Shelter” per scomodare il termine “capolavoro”.
“The Hurting”, dunque. La miglior seduta psicanalitica riuscita a un gruppo synth-pop. Perché i giovani Roland Orzabal e Curt Smith, appena fuoriusciti da un quintetto ska (i Graduate), sono letteralmente ossessionati dalla psicanalisi e in particolare dalle teorie di Arthur Janov, autore di quel “Primal Scream”, l’urlo primordiale, che aveva già ispirato John Lennon (vedi “John Lennon/Plastic Ono Band”, 1970) e che avrebbe poi regalato il nome a un’altra band leggendaria del Regno Unito. Le lacrime possono sostituire le paure, sostiene Janov: Tears for Fears.
L’idea iniziale – come ha rivelato Smith – era quella di guadagnare con la musica abbastanza denaro per permettersi la terapia, allora costosa e disponibile solo in posti tipo New York o Los Angeles. In alternativa, c’era la più economica possibilità janoviana di tirar fuori tutto attraverso le canzoni. Ecco allora “The Hurting”, il dolore, sparso ovunque nel disco, dai titoli – “Ideas As Opiates”, “The Prisoner” (of pain), già capitoli di libri di Janov – ai testi, a partire proprio da “Mad World”: “And I find it kind of funny/ I find it kind of sad/ the dreams in which I’m dying are the best I ever had” (ecco perché il brano è stato inserito in “Donnie Darko”).
I due membri dei Tears For Fears, figli di famiglie lacerate dai divorzi, cresciuti con madri lavoratrici e poco presenti, sentivano che i loro genitori – per dirla con le parole di “Pale Shelter” – non avevano dato loro amore, ma solo un pallido rifugio. Cicatrici che si rispecchiavano in un’adolescenza solitaria, tutta ripiegata nella musica, al punto da non potersi permettere il college o l’università per via di precoci impegni discografici. E i traumi infantili, rievocati fin dall’iconica copertina (con il piccolo Gebbie Serafin-Jaeger mani nei capelli), aleggiano ovunque, dai cori di “Suffer The Children” ai ricordi scolastici della solita “Mad World” (“Hello teacher tell me what’s my lesson/ look right through me”) fino a dare l’idea di un concept psicoanalitico, ipotetico successore di quel “The Wall” che era ancora in tour al tempo della composizione di questi brani, nel 1981.
All’alba del decennio più glamour, già impazzano i suoni sintetici, ma Orzabal (la mente creativa della ditta) è uno di vecchio stampo. Un beatlesiano, un fan di Peter Gabriel. Scrive tutte le canzoni con la sua chitarra acustica, nella città natia di Bath. Smith, conosciuto a tredici anni quando cantava i pezzi dei Blue Oyster Cult, lo asseconda alla voce. È l’incontro col tastierista Ian Stanley a rivelare al duo l’uso dei sequencer. Una scoperta cruciale: la tecnologia permette ai Tears for Fears di affrancarsi dal peso di una vera band, proiettandoli nel campo di quel pop sintetico che nel 1981 sarebbe poi esploso anche in classifica, con “Dare” degli Human League e “Speak & Spell” dei Depeche Mode. Anche il formato-duo ben si prestava all’operazione, non a caso sarebbe diventato un classico del decennio, dai Soft Cell ai Pet Shop Boys, dagli Eurythmics agli Yazoo.
Ai due ex-adolescenti tristi della middle class britannica si schiude tutto un mondo.
Quando nel 1983 arrivano a pubblicare il loro Lp d’esordio, Orzabal e Smith hanno già una solidissima reputazione, garantitagli da un poker di singoli da urlo, che costituirà l’ossatura di “The Hurting”. Il primo è uscito due anni prima e spiega già tutto: “Suffer The Children”. Un autentico j’accuse verso i loro genitori – “Cos he knows in his heart you won’t be home soon/ He’s an only child in an only room/ And he’s dependant on you” (“perché lui sa nel suo cuore che non sarai a casa presto; lui è un bambino solo in una stanza, e dipende da te”). Con tanto di dilemma apocalittico conclusivo: “The pain of birth/ What is it worth/ When it don’t turn out the way it should?” (“A che serve soffrire per la nascita, quando non va a finire come dovrebbe?”). Musicalmente, è un manifesto di quel mix di elettronica (le pulsazioni minacciose dei synth) e strumenti “veri” (la chitarra di Orzabal) che sarà il marchio di fabbrica della band, per un risultato che è pop nel senso più nobile del termine. Oltre al ritornello epico, la versione dell’album presenterà anche un topos radiofonico dell’epoca: il coro di bambini!
“Pale Shelter”, sfornata un anno dopo, fa ancora meglio, con l’elettronica che si distende in una ballata lineare e ariosa, sventagliata dagli interventi della chitarra acustica e riportata alla malinconia più maestosa dai synth sullo sfondo. Si aggiungano una melodia nostalgica e una vocalità ora decisamente più sicura da parte di Smith e si ha una vera madeleine del 1982, una perla malinconica che fa il paio con la “This Is The Day” pubblicata dai The The l’anno dopo.
A piazzare il colpo del ko, è però, nel dicembre dell’82, il terzo 45 giri, la pluricitata “Mad World”. Un prodigio che, in tre minuti e mezzo, condensa tutta l’enciclopedica cultura musicale di Orzabal: interi decenni di pop britannico, divorati e digeriti in lunghi anni di ascolti casalinghi e visioni televisive di “Top of the Pops”. È il mondo borghese, normale eppure “folle”, evocato a Orzabal dalla visione di Bath al mattino dalla finestra del suo appartamentino sovrastante una pizzeria (le “Worn out faces/ Bright and early for their daily races”), a trasformarsi nell’epos di “Mad World”. La ballata parte solenne nelle strofe, accompagnate da un cupo bordone di synth, per poi aprirsi in un ritornello urgente, dove le tastiere supportano la batteria in chiave percussiva, per distendersi infine nella ripetizione sognante delle parole del titolo. Il risultato è un capolavoro di dinamica, in cui l’elemento ritmico si sviluppa e cresce nel corso del brano, quasi assente nella prima strofa e invece propulsivo nella seconda, decisivo nei primi due ritornelli e addirittura martellante nel terzo, ma in grado di lasciar spazio alla stasi di quello che è il principale hook del brano: “Mad world, mad world”.
Quarto pilastro a 45 giri di “The Hurting” è “Change”, ovvero la dimensione più trascinante e corale dei Tears For Fears (quella di “Shout” e “Sowing The Seeds Of Love”, per intenderci), condensata in un brano ballabile, ben interpretato da Smith e portato avanti da una intro di elettro-xilofono, da un basso funkeggiante, da un carillion martellante di tastiere e marimba a mimare sonorità latine e dalle rasoiate della chitarra ritmica, per un insieme memore sia della black music più danzereccia sia della sua rilettura wave (l’anno precedente era già uscito “Duran Duran”).
Grazie a questa quaterna di hit, Orzabal riesce a passare rapidamente dallo status di spettatore a quello di protagonista di Top of the Pops. Quando “The Hurting” uscirà nei negozi farà ancora di più: conquisterà la vetta della Uk Chart scalzando nientepopodimeno che “Thriller” di Michael Jackson.
Ma “The Hurting” non è solo il greatest hits dei primi Tears for Fears. Anche i brani non editi come singoli si adattano alle tematiche cupe dei testi, giocando su un’elettronica d’atmosfera e ritmiche lente quanto intricate, figlie di ripetuti ascolti di “Peter Gabriel III”. Se l’iniziale title track è un’introduzione piuttosto lineare dei temi dell’album, tra prominenti linee di basso, ricami di chitarra e un tipico refrain cantato di Smith (“is it an horrific dream?”), altri episodi si presentano spesso meno strutturati, nella forma di ballate d’atmosfera, persino dotate di assoli al sax, come nel caso di una “Ideas As Opiates” densa di soul, che ricorda i pezzi cantati da Martin Gore nei tardi Depeche Mode, o di una “Memories Fade” affogata nella nostalgia, con il ticchettio del piano ad assecondare la riflessione languida di Orzabal sui ricordi che sbiadiscono mentre le cicatrici restano (“Memories fade but the scars still linger”).
In altri casi si va dalle parti di una new wave elettronica piuttosto oscura, come nel caso di “Watch Me Bleed”, che replica in chiave più dark la formula dei primi singoli con la chitarra acustica e un testo sinistro (“Watch me bleed/ Bleed forever”), o di una paranoide “The Prisoner”, tutta giocata sulla texture dei suoni (con l’influenza dichiarata di “The Intruder”), più che su melodia e testi.
Gran finale col piano e le tessiture malinconiche (ma anche i colpi di drumming tribali) di “The Start Of The Breakdown”, riassunto emotivo dell’intero disco, dove Orzabal ricorda dolorosamente la malattia e il crollo nervoso del padre, portando a compimento l’idea di fondo dell’opera: proiettare al di fuori i ricordi e la sofferenza per liberarsene e non doverli più reprimere. Gran parte di questi brani, a differenza dei singoli, vedono Orzabal impegnato al canto, con i suoi vocalizzi soul, e uno Smith più defilato, che si limita a suonare il basso.
Forte di una scrittura sofisticata e di un sapiente equilibrio tra strumenti acustici (oltre alla chitarra di Orzabal, il sax di Mel Collins e le chitarre di Phil Palmer) e confezione sintetica, “The Hurting” sposa l’irresistibile appeal pop con una inquietudine personale che è la cifra dei migliori gruppi del decennio (dai Cure ai Cocteau Twins) ed è proprio l’elemento sfuggito agli emuli “nu new wave” del Duemila, che si dedicheranno a un dignitosissimo intrattenimento, ben distante dalle rabbie giovanili colte invece da altre correnti musicali del periodo.
Negli anni non sono mancati omaggi – dai Mansun agli Smashing Pumpkins – e citazioni più o meno esplicite. Ma l’influenza di “The Hurting” è andata ben al di là del rock, se è vero che a reclamarlo come fonte d’ispirazione sono stati anche artisti r’n’b americani come Wyclef Jean o Black Sheep. Le dichiarazioni di stima dal mondo hip-hop evidenziano una propensione dance che spunta fuori anche nei successi più lineari dei Tears For Fears (quel basso disco che spinge il finale della romantica “Pale Shelter”), e che invece alle orecchie del pubblico rock suona ora datata, tanto da rendere necessaria la “ripulitura” di “Mad World”. Forse nel 1983 il linguaggio pop era meno codificato per generi, ecco forse una possibile ragione della attrazione-repulsione per gli anni 80 che ha caratterizzato il primo decennio del nuovo secolo.
Ma, al di là di tutto, “The Hurting” resta un disco praticamente perfetto, dall’inizio alla fine. E, con tutto il rispetto per l’apprezzabile cover di Jules, lasciateci aggiungere che la “Mad World” originale non si batte. I ricordi sbiadiscono, ma le belle canzoni restano.
Claudio Fabretti, Lorenzo Salzano