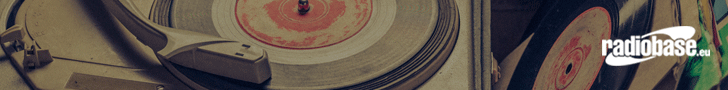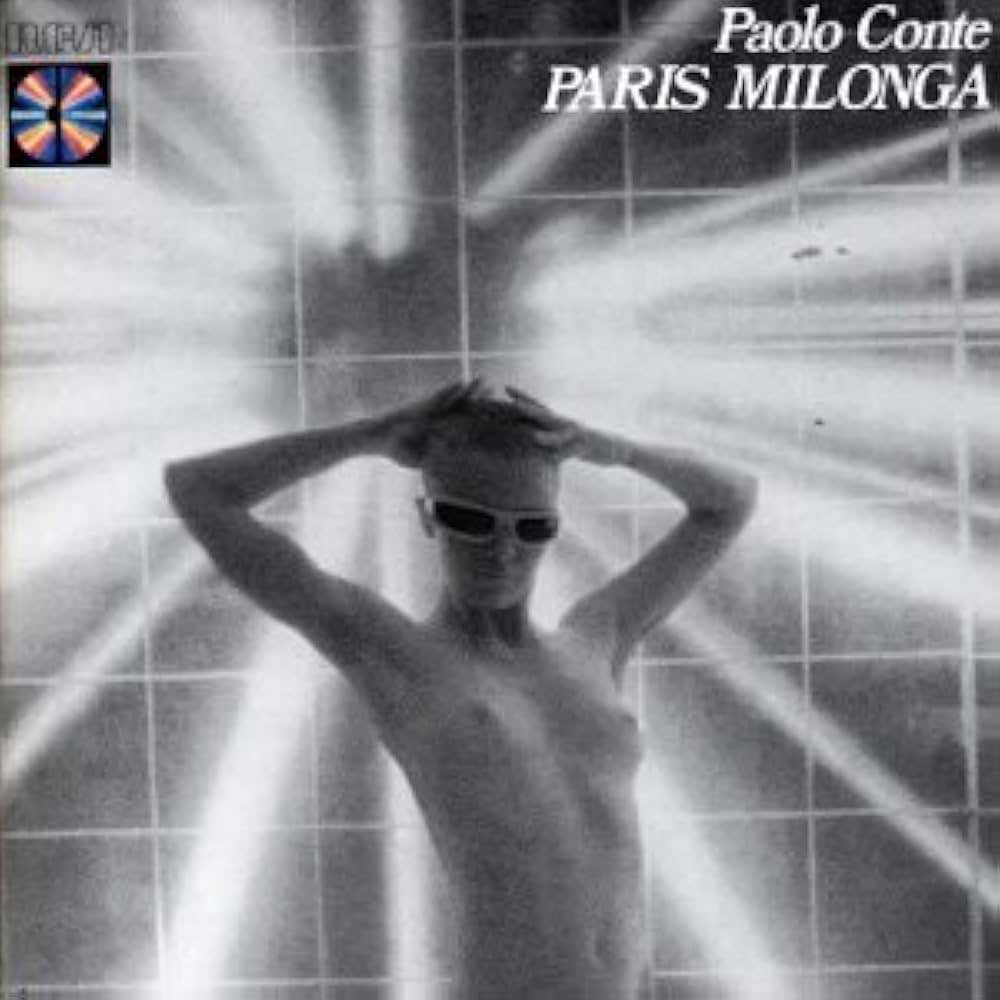
Paolo Conte
“Paris milonga”, 1981 (Rca)
Jazz, swing, songwriter
di Fabio Guastalla
Mentre il calendario compie il giro di boa dagli anni Settanta agli Ottanta, Paolo Conte imprime la svolta decisiva alla propria carriera. L’autore timido, il riluttante interprete di sé stesso che attraversa oltre un lustro in un crescendo di stile e autostima, sboccia completamente agli esordi del nuovo decennio. Per usare una di quelle metafore ciclistiche su cui l’avvocato astigiano ha costruito intere epopee, nel 1981 Conte è il campione ancora inespresso che all’improvviso, ma forse nemmeno troppo, decide di rivelare tutta la forza e il talento che lo contraddistinguono, cambiando il rapporto all’inizio della salita più importante, quella in cui si decide tutto, e prende un ritmo che nessun altro riesce a tenere, fino a ritrovarsi al gran premio della montagna nella più totale solitudine. La salita non può che essere il Tourmalet, poi c’è la discesa ed è un bagno di folla.
In realtà, come sempre o quasi, le cose sono diverse da come le si sintetizza a posteriori. Quando esce “Paris Milonga”, nel 1981, Paolo Conte non è certo uno sprovveduto. Ha scritto per altri diversi brani di successo, da solo e in compagnia (anche del fratello Giorgio, altro indiscutibile talento). Brani nei quali si riconoscono le avvisaglie di un talento laterale nello stile e nel linguaggio rispetto a qualsiasi altro autore, ma comunque influenzati dalle richieste della fiorente industria discografica italiana. I due omonimi album, quelli con cui “rompe il ghiaccio”, per quanto di indubbio valore, sembrano risentire di questo clima, ma già con “Un gelato al limon” del 1979 la necessità del bardo astigiano di dirigersi verso orizzonti più ampi e un immaginario “autonomo” e tutto da inventare inizia a farsi sentire. “Paris Milonga” è l’istante in cui la visione musicale e lo stile letterario di Paolo Conte escono definitivamente allo scoperto e trovano una forma e una sostanza che non ha, e non può avere, paragoni.
“Paris Milonga”: se la controversa copertina dell’album non racconta assolutamente nulla di ciò che contiene, il titolo da parte sua non potrebbe essere più azzeccato. È come se Paolo Conte volesse misurare i nuovi confini del suo fare musica, fino ad allora sostanzialmente ristretti a una visione regionale/italiana: da una parte il Sudamerica, con il suo fascino irresistibile e già in parte omaggiato due anni prima con brani come “Sud America” (appunto) e “Blue Tangos”; dall’altra la Francia, raffinata ed esigente, di cui forse il Piemonte, per l’autore, non è che una delle tante province. Quel che sta nel mezzo lo si scopre durante il cammino, inteso come l’intera parabola artistica.
Va poi detto, ed è tutt’altro che banale ribadirlo, che questo album non sarebbe stato ciò che è senza le persone che hanno affiancato Conte nell’impresa. Il ritorno di Lilli Greco in cabina di regia mette l’avvocato a suo agio, perché per Greco ciò che conta è l’interpretazione così com’è, anche quando non può avvicinarsi alla perfezione di una incisione standard in studio. Ecco dunque che più di una canzone contenuta in “Paris Milonga” proviene dritta dritta dai provini, assecondando l’espressione: “Buona la prima”.
Negli studi della Rca di Roma, inoltre, Conte è circondato da musicisti che in parte, da lì in poi, lo accompagneranno lungo il cammino. Oltre al fidato Claudio Dadone, appaiono per la prima volta il chitarrista Jimmy Villotti, l’organista Felice “Happy” Ruggiero, il batterista Lele Melotti, giusto per citarne alcuni. Con un’orchestra a disposizione, la fantasia dell’astigiano trova terreni ancora più fertili.
Dello sterminato canzoniere uscito dalla penna di Paolo Conte, “Via con me” è – insieme ad “Azzurro” – con ogni probabilità il brano più celebre, e per molte buone ragioni. In primis perché rappresenta e sintetizza mirabilmente il modo di essere e di fare arte dell’avvocato: elegante e sornione, leggero e disincantato, sognante ma irriverente, con l’introduzione quasi copernicana del verso onomatopeico (“du du du du du/ ci bum/ ci bum bum”) a stemperare e a rendere in qualche modo universale l’insieme, una marcetta/vaudeville per piano che ci mette ben poco a entrare in testa.
Ben più sacra, nei toni, è la parabola di “Alle prese con una verde milonga”. Un brano che attanaglia nella sua irresistibile indolenza, ma anche e soprattutto un atto d’amore verso la musica sudamericana, esplicitato non solo nella metrica, ma anche nei riferimenti testuali e in particolare nell’omaggio esplicito ad Atauhalpa Yupanqui, fuoriclasse argentino della chitarra che Conte aveva avuto modo di ammirare al Premio Tenco nel 1980. Se già con “Un gelato al Limon” il linguaggio si era arricchito di immagini, metafore e stratagemmi, con la verde milonga si toccano nuove vette di lirismo: “La sua origine d’Africa/ la sua eleganza di zebra/ il suo essere di frontiera/ una verde frontiera/ una verde frontiera/ tra il suonare e l’amare/ verde spettacolo in corsa da inseguire/ da inseguire sempre/ da inseguire ancora/ fino ai laghi bianchi del silenzio/ finché Athaualpa/ o qualche altro Dio/ non ti dica: ‘descansate niño che continuo io'”.
Il gioco di sponde vede Conte passare da un habitat (reale ma reinventato) all’altro, con quella fluidità di immagini e di parole che diventano marchio di fabbrica. “La vera musica” sfoggia un vestito di grande classe in quello che è un omaggio all’arte di creare note nelle sue più sperdute, mirabili accezioni. La malinconia di “Blue Haways” è in realtà un affare tutto privato e ben poco esotico, a dispetto del titolo e di un ritornello declamato in un improbabile inglese. Sembra di essere in uno di quei fumosi piano-bar di una volta, che poi è il terreno di conquista di “Boogie”, un ibrido tra blues e jazz nel quale per la prima volta l’astigiano si compiace di farsi accompagnare dalla sua big band nuova di zecca.
A mezza strada tra il Sudamerica e la Francia si pone “L’ultima donna”, tra accenti swing e spirito da cabaret, ma in realtà è semplicemente l’omaggio al maestro per eccellenza, Georges Brassens, e alla sua “La première fille”.
E dunque, la Francia. “Madeleine” si sviluppa attorno ai giri di pianoforte incalzati dalla marcetta in cassa rullante a soffiare sulle ceneri di una malinconia forse proustiana, indubbiamente transalpina nel sottofondo musicale e poetico (“Allons, Madeleine/ certi gatti o certi uomini/ svaniti in una nebbia o in una tappezzeria/ addio addio, mai più ritorneranno, si sa/ col tempo e il vento tutto vola via”). Poetico è anche il brano forse meno celebrato del disco, “Un’altra vita”, introdotto da uno dei più bei temi per pianoforte tra gli innumerevoli scritti da Conte. Che alla fine non può esimersi dal rendere omaggio alla città per eccellenza, Parigi, la stessa Parigi che da lì in poi gli spalancherà le porte dei suoi teatri. Una dichiarazione d’amore duplice, a una donna e a un luogo che finiscono con l’immedesimarsi (“mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e Francia”).
In quanto a “Pretend Pretend Pretend”, sarebbe di per sé un capitolo alieno rispetto al contesto, ma ha un valore funzionale. Alla sua maniera, Paolo Conte riaccende i riflettori e ci fa intuire di essere entrati nel suo teatrino, nel quale noi siamo gli spettatori ed egli stesso è il protagonista. Cambia il decennio, cambiano le prospettive. Non ci sono più maschere da indossare, ma legioni di platee da conquistare.