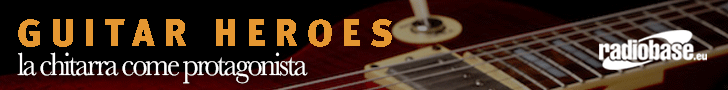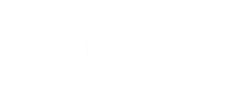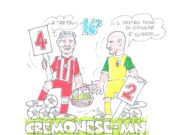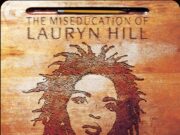Questa rubrica che “vado a incominciare” come si diceva una volta in gergo teatrale, risponde ad una mia vecchia passione e spero che risponderà anche agli interessi dei lettori e degli ascoltatori di Radiobbase: la voglia di riscoprire le tradizioni e le leggende locali, le radici appunto, che si vanno via via perdendo nella memoria delle recenti generazioni. Non vuole essere un percorso dotto, né troppo ambizioso: mi accontenterò di spulciare qua e là gli scritti di autorevoli studiosi che mi hanno preceduto in questa passione, scegliendo, semplificando e riportando – spero non troppo indegnamente – le cose di una volta, ricordando il tempo delle abitudini scomparse, delle filastrocche perdute, dei mestieri che non si trovano più …
L’autore che più mi ha affascinato in questo ambito e che mi ha regalato il piacere di tanti racconti sulle radici è Giovanni Tassoni, viadanese, “scienziato delle tradizioni” e, purtroppo scomparso. A lui dedico questa mia rubrica e spero mi perdoni se saranno proprio i suoi libri la fonte principale di saccheggio per le mie informazioni[1].
Il ciclo dell’anno: dai giorni della Merla al tempo della Candelora
I tri gioran dla Merla sono gli ultimi tre del mese di gennaio e dovrebbero essere, se la tradizione viene rispettata, i più freddi dell’anno. Ma perché questi tre giorni si chiamano così? A quali leggende fa riferimento la citazione della Merla? Due sono le storie che i nostri vecchi si raccontavano in proposito. La prima torna indietro al tempo in cui i merli avevano le penne bianche e, nello specifico, ci parla di una merla incauta che, alla fine di gennaio, uscì festosa a saltellare, approfittando di un’insolita mitezza del clima e ritenendo che l’inverno ormai fosse passato. Mal gliene incolse, dice il racconto, perché gennaio si impermalì, fece tornare per tre giorni vento e neve e costrinse la merla a rifugiarsi in fretta in un camino da cui uscì – inevitabilmente ( e con lei in seguito tutti gli uccelli della sua specie) – di colore nero fuligginoso.
La seconda storia sulla merla parla di una coppia, merlo e merla (bianchi, naturalmente) alla ricerca disperata di cibo negli ultimi giorni di gennaio, quell’anno particolarmente gelidi. Il merlo, cavallerescamente, si offrì di perlustrare campagne e strade per tutti e due: fece aspettare la sua bella e per tre giorni cercò e cercò. Finalmente, trovato un prezioso granello di frumento dimenticato, tornò per portarlo alla sposa. Ma la merla non fu più trovata: si era rifugiata, per scaldarsi, in un camino e ne era uscita così nera che nemmeno il suo amoroso consorte la poté più riconoscere!
Ma lasciamo queste leggende su un Gennaio che ormai è scivolato velocemente in Febbraio e occupiamoci di questo “febbraietto, corto, corto e maledetto!”. Era tempo, soprattutto per i contadini di una volta, di scrutare cielo e clima, per avere anticipazioni sull’esito dei raccolti. Bene: bastava arrivare al 2 di questo mese, giorno della Candelora, per avere le previsioni del tempo che sarebbe venuto. Dicevano infatti, soprattutto in campagna, quando erano ancora lontani i tempi delle cartine metereologiche e dei telegiornali, che il clima sarebbe stato brutto se febbraio fosse cominciato col sole:
“Se bat al sol in sal Candlìn, poar povrìn!” oppure “S’a bat al sol in sla Candela la sarà na brüta primavera”.
In ogni caso, la festa della Candelora prende il nome dalla Candelina che, il 2 febbraio, i devoti andavano a ritirare in chiesa: una candelina benedetta, che veniva poi appesa al muro e serviva a molti scopi benefici: scongiurava la grandine, aiutava a tener lontane le malattie, curava le screpolature dei piedi e (sgocciolata) le scottature.
Tuttavia febbraio iniziava con altri santi che proteggevano da malanni e malattie: per San Biagio (il tre febbraio) si usava (e forse si usa ancora) farsi “benedire la gola” dal sacerdote, mentre Santa Apollonia (il nove febbraio) era invocata contro il mal di denti, a memoria del martirio cui la santa fu sottoposta quando, nel III secolo, i suoi carnefici le spezzarono i denti, rompendole le mandibole. Era proprio santa Apollonia che, secondo un’antica tradizione popolare del mantovano, raccoglieva i denti di latte dei bambini, collocati sulla mensola del camino, e lasciava in cambio una moneta in segno di gradimento.
E, finalmente, dopo le preoccupazioni e i guai dell’inverno, anche i nostri bisnonni si concedevano la spensieratezza del Carnevale!….
[1] V. G. Tassoni: Tradizioni popolari del mantovano, Olschki editore, 1964.